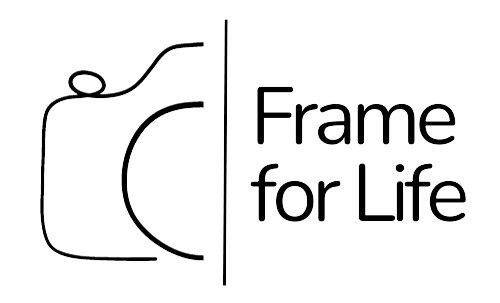Short bio su Negrini, link clicca qui
Alessandro Negrini, siamo felici di condividere con lei l’inizio del percorso delle interviste dell’Associazione Frame for Life. Iniziamo subito con la nostra prima domanda “CHE COS’E’ IL CINEMA PER LEI?”
Bella domanda… il cinema è uno strumento potentissimo per far si che ciò che normalmente nella storia privata o collettiva è invisibile agli occhi, diventi visibile.
Un esempio che faccio spesso e che è all’origine del mio far cinema, è il quadro “una domestica per la cena in Emmaus” di Diego Velazquez. Dal dipinto emerge il volto stanco della serva, pensoso, e dietro sullo sfondo c’è una finestra passa-vivande e attraverso la quale si vede la Cena di Emmaus di Gesù, la prima apparizione dopo la sua morte. Beh, la meraviglia è che quell’evento viene per la prima volta raccontato da chi era dietro, invisibile e nascosto, da chi finalmente acquisisce uno sguardo, un’identità.
Ecco per me il cinema è questo, far venire avanti chi normalmente sta indietro.
Nel cinema quello che rimane sullo sfondo ha finalmente un volto, una storia. Tutti noi siamo fatti di tante storie invisibili e il cinema per me ha questo potere straordinario, di dare una storia visibile a chi sta dietro.

Per noi di F4L cinema e fotografia sono due mezzi utili a sensibilizzare sulle cause sociali più urgenti, sulla necessità di tutela dei diritti umani, su questioni che necessitano di soluzioni. E quindi mi interessa molto sapere, a proposito di ciò che diceva, se e come può -secondo lei- il cinema avere un ruolo attivo nella difesa dei diritti umani?
Io sono convinto che il cinema sia nella sua natura portato a svolgere questo ruolo, perché anche quando racconta la storia più nichilista che c’è, anche quella più dolorosa o disfattista, veicola un senso che oggigiorno è spesso addormentato, se non amputato, che è il senso dell’incanto: il riuscire a ricordarsi che la magia e il sogno sono un diritto.
C’è uno scrittore uruguaiano che diceva che nelle Costituzioni di tutto il mondo, bisognerebbe inserire il diritto al sogno. Che non è una cosa astratta, ma la più concreta che c’è, cioè poter veicolare l’idea di rimanere “persone” ovunque ci si trovi, come paziente in un ospedale, come studente di una scuola, come lavoratore in una fabbrica e così via. Ecco questo deve rimanere immutato e immutabile.
E questo accade quando non siamo disincantati, quando non pensiamo che tutto sia immutabile e per sempre. E in questo processo il cinema ha un ruolo enorme, potentissimo. Anche soltanto per il principio per il quale davanti ad uno schermo si ridiventa bambini. E i bambini non sono disincantati, per quanto il sistema in cui viviamo voglia che lo siano, il cinema questo lo impedisce (il video SI INTERROMPE)
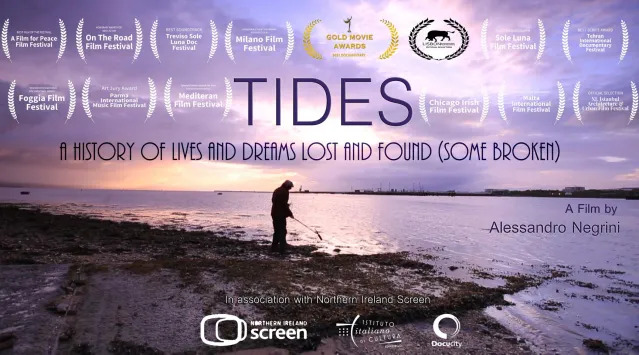
Quello che ha detto mi fa pensare alla possibilità per il cinema di arrivare a suggerire o ricercare soluzioni di fronte alle fragilità e alle problematiche sociali, anche le più complesse. Ecco vorrei tanto sapere se le è mai successo con i suoi film di poter intervenire sulla realtà?
La risposta è si, mi è successo in maniera rocambolesca e ingenua con il film “Paradiso”, che girai anni fa in Irlanda del Nord, e che è intervenuto sulla realtà anziché solo rappresentarla. In questo luogo di grande separazione tra cattolici e protestanti, una sera ero ad un bancone di un pub insieme ad un grande musicista Royal Bacon, ed ero pensieroso perchè girando questo film mi mancava ancora un elemento di concretezza. Cercavo però una concretezza sognante, che non fosse amputata dell’utopia. La parola utopia oggi è svilita ma ha un significato meraviglioso: il regista Fernando Birri alla domanda “che cos’è l’utopia?” rispondeva “è quella cosa che quando tu ti avvicini di tre passi, lei si sposta di tre passi” e la giornalista gli chiese “ma allora a cosa serve l’utopia?” e lui rispose: “a farci camminare, ad andare avanti”
Quel senso “utopico “ emerse così ingenuamente anche nella mia serata al pub con questo musicista, gli dissi “e se noi questi cattolici e protestanti li facessimo ballare tutti insieme? Ci inventiamo una serata danzante e la inseriamo nel film?”, convinto che mi prendesse per matto. E invece rispose “ci penso”. E quello fu l’inizio, iniziammo a camminare. E la serata danzante avvenne, come scheletro portante del film, non vi svelo il finale ma quello che avvenne fu davvero uno sguardo travalicante il confine dell’accettazione del reale, divenne parte del film e soprattutto parte della realtà: cattolici e protestanti ballarono insieme. E il fatto che accadde una volta, ci ricorda che tutto può accadere, anche quando tutto il mondo ti dice no, non puoi.

Vorrei farle ora una domanda pensando ai giovani, a chi si avvicina alla sua professione oggi, soprattutto pensando ad un/a giovane collega appassionato/a di tematiche sociali, di diritti violati: cosa si sentirebbe di consigliare loro?
Ah, intanto io mi considero un giovane regista sotto tantissimi profili, sia perché mi piace rinascere in ogni film che faccio, e soprattutto perché ho iniziato tardi.
Da “giovane regista” dunque consiglio, innanzi tutto, le parole del mio amico fotografo Mario Dondero. Diceva sempre che per lui lo scopo ultimo era quello di far capire che il soggetto fotografato non era importante perché lui doveva fotografarlo, ma perché “esisteva”, e nel suo esistere, gli stava raccontando un pezzetto di storia non ancora narrata fino a quel momento. Non foss’altro perché lo sguardo su quella storia cambiava, e lo sfondo appunto, veniva avanti. E quindi il tema del rispetto della dignità delle persone che filmi, ecco questa è per me una tematica fondamentale da suggerire a chi si avvicina alla professione.
Il secondo consiglio che mi viene in mente è di non farsi mai “domare lo sguardo”, soprattutto nel desiderio di raccontare la storia come si vuole, perché il regista incontrerà tantissimi tentativi per addomesticarlo e renderlo meno pericoloso. Anche nei momenti più difficili, bisogna sempre che mi ricordi le parole di un signore irlandese in un pub che guardandomi mi chiese “ehi, tutto ok?” e io risposi “si, si sto soltanto …pensando” e lui andò al bancone, tornò con un whiskey e fece un gesto che mi porto ancora dentro come una lezione, che vorrei passare a chiunque si appresta a voler raccontare un pezzetto di vita umana o una storia. Si avvicinò, mi mise la mano sotto il mento e alzandomelo, mi disse: “pensa alto”.
Una poesia concreta, che mi insegnò che anche nei momenti più difficili, in cui tutto il mondo ti dice che non puoi, tu devi pensare con lo sguardo non domato, alto, per non perdere il resto della visione.

Mi piacerebbe infine parlare del suo ultimo film “La Luna sott’acqua”, anche per capire e conoscere la reazione degli ertani che lei ha reso parte del film, protagonisti principali: come si è relazionato con loro durante le riprese? Come ha gestito questa relazione complessa e delicata?
Questo film non avrei potuto realizzarlo senza la fiducia degli ertani e senza il loro sostegno. E’ un film con gli ertani. Sono successe cose meravigliose, anche quando eravamo in difficoltà, ma la cosa più bella che considero il mio premio oscar, è accaduta quando abbiamo proiettato a Pordenone, dove vennero in sala gli ertani protagonisti del film, e uno di loro mi disse: “questo film ci piace perché dentro il film non c’è solo la morte, ma c’è molto di più”. Certo fare un film sul Vajont, storia di grandi colpe e di morte premeditata, con poche condanne e poca giustizia, spesso narrata male, (o totalmente inenarrata per quanto concerne il post-Vajont di cui si parla nel film), significa mettere in scena una trama dove la morte purtroppo ha un ruolo preponderante. Ma nel film c’è anche la vita che fuoriesce, come l’immagine incredibile dell’albero orizzontale che è riuscito a sopravvivere e rinascere, immagine che colpisce tutti e lascia un segno indelebile. Ecco, sentirmi dire quella frase, per me la medaglia più bella. E io li ringrazio molto per questo.