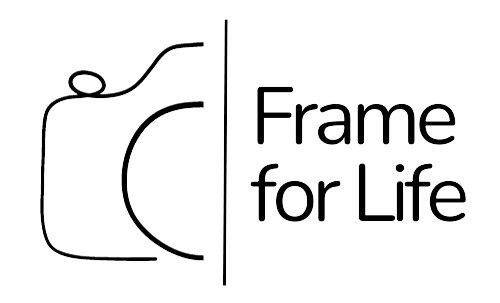Marco Palombi, fotografo freelance di reportage. Da una quindicina d’anni nel sociale, è un fotografo conosciuto e stimato con una lunga storia di reportage e pubblicazioni sui maggiori quotidiani e riviste nazionali, ha svolto tanti servizi in situazioni di conflitto e crisi umanitarie nel mondo.
Ci piace ricordare l’ultimo suo grande successo, a novembre del 2023 Marco ha vinto il “Premio Anima per la fotografia etica” (insieme a Matteo Garrone per il Cinema, con film “Io capitano”).

“Marco grazie davvero per questa intervista per Frame for Life.
Vorrei partire da te, dal tuo modo di fotografare che tocca le emozioni e l’anima di chi guarda le foto, anche di chi non conosce la tematica di cui parli. Come definiresti il tuo modo di fotografare? Cosa cerchi, cosa ti appassiona di più del tuo lavoro?”
Sono sempre stato spinto dalla curiosità di visitare mondi diversi e posti lontani e facendolo, con il mio obiettivo ho cercato -nel tempo- di dare voce a persone a luoghi magari anche sconosciuti. In questo modo ho scoperto e ho preso la strada del reportage fotografico e così ho trovato la mia strada fotografica. La cosa prioritaria per me è quando entro in questi luoghi lontani e quando viaggio è entrare in contatto con le persone e chiaramente con l’ambiente che le circonda per condividere con loro la loro vita quotidiana e soprattutto passare tempo con loro, a volte anche stare seduto in un angolo e solamente aspettare che succeda qualcosa -e qualcosa succede sempre.
Quello che faccio quindi si, è raccontare storie delle persone attraverso le immagini. Spesso si tratta di persone che sono costrette a lasciare la loro terra, la loro casa per via di cambiamenti climatici, guerre o povertà. E’ incredibile come ogni volta mi arriva forte un messaggio, che mi lascia a bocca aperta, e realizzo ogni volta come queste persone non abbiano avuto il privilegio che ho io, essendo nato nel posto fortunato del mondo, e sono costrette a fuggire.
“Come ti poni di fronte alle tragedie, ai drammi, che ti sei trovato spesso a fotografare? Soprattutto che tipo di relazione o “patto” instauri con le persone che fotografi? Non è facile, soprattutto in mondi così lontani dal nostro, riuscire ad avere le persone là davanti che ti guardano negli occhi e che si fanno fotografare l’anima… com’è la tua relazione con loro, come ti poni?”
Entrare in questi in questi luoghi è veramente è difficile, ti senti spesso inutile e piccolo, a disagio. Tu sei li a voler raccontare, ma lì c’è la guerra, cosa puoi fare tu con la macchina fotografica? dove ci sono guerre c’è una sensazione di sconforto che diventa sempre più grande nei giorni successivi e ti rendi conto che le persone che poi muoiono in questi posti sono quasi tutti civili, e nessuno vuole la guerra, se tu lo domandi alle persone e ai sopravvissuti alle persone che stanno lì: la guerra giusta? non giusta? Nessuno di loro vorrebbe essere in guerra. Io cerco allora di avere un approccio diretto con i singoli, non con la problematica generale. L’approccio è dunque legato alla conoscenza delle singole persone e la conoscenza delle loro vite, sempre chiedendo “ il permesso” di entrare nelle loro vite, nelle loro case, e ovviamente anche il permesso di fotografare. Esistono colleghi che per una buona foto prendono le persone le spostano le mettono davanti all’obiettivo per creare una storia ecco, no, quello io non lo ritengo giusto non lo voglio fare, non lo posso fare, preferisco fotografare quello che accade con grande rispetto.

“Dunque Marco, qui non posso fare a meno di chiederti: cos’è per te l’etica in relazione con la fotografia?
In modo particolare con questa narrazione fotografica la dignità delle persone per me viene al primo posto, è centrale, e quindi ci sono delle regole da rispettare.
E a volte ci si deve fermare e si deve lasciare la macchina fotografica, anzi spostarla e ascoltare le persone, o magari anche aiutarle. Vi posso fare due semplici esempi: una volta ero ad Haiti ad un anno esatto dal terremoto del 2010 quindi stavo lì esattamente nel 2011 ma era come se fosse successo tre giorni prima, mi sono trovato a fotografare e a fare video e in un contesto veramente drammatico. Ecco lì io non me la sono sentita e soprattutto nella cattedrale distrutta dove c’erano ancora i morti sepolti, mi sono detto no non voglio chiedere a nessuno se posso fotografare, ho fatto degli scatti ma poi mi sono fermato, non me la sono sentita.
Oppure una volta lavorando con Emergency al porto di Augusta in Sicilia dove ci fu uno sbarco di 158 persone di cui 40 erano morti: dovevo raccogliere le testimonianze. Queste persone mi chiedevano di ricaricare il loro telefonino per avvertire la famiglia che erano arrivati vivi. Beh, io ci ho messo due giorni prima di fare il mio lavoro perché in alcuni casi non si può, ci si deve fermare.
“Una domanda prettamente fotografica: in base a cosa scegli se il tuo reportage sarà colori o in bianco e nero? Come fai questa scelta?”
Dunque, quando ho iniziato a fotografare mi poiaceva il bianco e nero perché lo ritenevo molto più di impatto, forse perché mi piace il ritratto e il bianco e nero dava una certa atmosfera e mi sembrava più surreale e cercavo composizioni. Poi negli anni ho riguardato le foto a colori e ho continuato a cercare questo aspetto surreale e alla fine ho scelto di fare tutto in bianco e nero come essere tornati un po’ indietro nel tempo e anche le foto ultime a colori le ho le ho girate in bianco e nero, come hai visto alle ultime mostre, come “Passi”.
Ma ho usato anche il colore, e soprattutto in Africa e spesso in Medio Oriente negli ultimi reportage che ho fatto, perché anche con il colore ho trovato un elemento di surrealtà o talvolta perché il colore mi trasmette un immagine di gioia, che si trova nella vita di tutti giorni anche dei posti più difficili. Non faccio mai una scelta prima di partire, decido in base al mio sentire lì sul posto.

“Perché hai questa necessità di ottenere un’immagine surreale? è una scelta estetica o ha anche un altro significato?
In alcuni luoghi il surreale mi permette di dare alle foto un impatto emozionale più forte, giocare un po’ con la luce e poi sai anche in un campo profughi ci può essere un momento di gioia di queste persone che hanno perso tutto che però in un attimo puoi ritrovare luce e vita, e allora il surreale ti fa immaginare questo contrasto e questo impatto fuori dagli schemi.
“Il fotografo è un testimone ed eventi, ma non può non essere parziale con la sua fotografia. Ecco, da questo punto di vista, credi che la fotografia sia cambiata negli ultimi trent’anni?”
Beh sì assolutamente la fotografia è cambiata prima di tutto perché eravamo nell’era analogica e partivamo con i rullini. Era bello ritrovare dei lavori che avevi fatto magari un mese prima e vedere come avevi lavorato.
Adesso è cambiato tutto nel senso tu la foto la guardi, la cancelli e la rifai: l’approccio è molto più veloce, adesso con i social va tutto di corsa. Spesso si preferisce un video piuttosto che una galleria fotografica, perché l’impatto è più immediato. Però si perde il “tempo dedicato alla riflessione”, la riflessione sul progetto, su quello che vuoi comunicare, e poi mi accorgo che pensavo di più prima di scattare… beh ci pensavo perché all’epoca i rullini costavano, ma anche perché c’era quella magia di scattare al momento giusto.

“Marco, tu spesso lavori a fianco di ONG, agenzie o Enti non profit, vorremo dare qualche elemento a chi vuole avvicinarsi, come fotografo o videomaker, a questo genere di lavoro: come funziona la partnership? Ti cercano loro, ti proponi tu? E come si svolge il tuo lavoro sul campo al loro fianco?
Ho iniziato ad autofinanziare i miei progetti di reportage, come penso la maggior parte delle dei fotografi all’inizio, poi gli proponevo ai giornali e ho iniziato così dopo un lungo periodo di lavoro con le agenzie, ho iniziato a vendere delle foto alla Repubblica e alla stampa etc.
Con il tempo hanno iniziato a chiamarmi loro, avevano bisogno di un fotografo e di uno che faceva anche video, ovviamente è un rapporto molto importante quello con i giornalisti con cui parti perché ti ci devi trovare e devi avere una sintonia.
L’importante è sapere dove arrivi e quello che succede nel posto e la cosa più sicura soprattutto è affidarsi alle ONG o alla Agenzie, sanno dirti “qui non si può andare non si può fotografare in questo posto lo devi fare non lo devi fare” e devi assolutamente attenerti a quello che ti dicono anche perché a volte arrivi in un posto e ti eri fatto un’idea completamente diversa, devi riformulare il progetto che avevi in testa. Le organizzazioni e i loro operatori sul campo ti aiutano su questo aspetto e poi spesso nasce una relazione personale e umana, e da lì si sviluppano le prime collaborazioni.
“Quanto ritieni sia importante la fotografia per comunicare le tematiche sociali, e la ritieni sufficiente per attivare le coscienze oppure comunica un’emozione ma non sempre porta dei risultati? Hai qualche esempio da raccontarci? Magari qualcuno che si è attivato dopo che ha visto una tua foto.”
Domanda importantissima e fondamentale questa.
Un esempio te lo posso fare con uno degli ultimi lavori, un anno e mezzo fa sono stato in Tanzania con Comunità Solidali nel Mondo che hanno un progetto sui disabili e un progetto diciamo difficile ma tanto importante, perché i disabili in Africa sono gli ultimi degli ultimi. Ho conosciuto i ragazzi del servizio civile quindi dei giovani italiani che stanno lì per sei mesi e che hanno anche serie difficoltà perché si parla non solo della capitale verso di andare nei villaggi al confine con lo Zambia nei posti insomma complessi. Al ritorno insieme all’associazione abbiamo organizzato una mostra fotografica qui a Roma e 3 giorni di incontri e dibattiti con i ragazzi delle scuole italiane che si sono messi in contatto sempre via web con i ragazzi del servizio civile che stavano in Tanzania. E’ stato emozionante, anche perché i ragazzi italiani volevano sapere e hanno conosciuto una realtà completamente diversa, e poi hanno organizzato delle donazioni per l’Associazione oltre ad un arricchimento personale meraviglioso e mi ha fatto sentire il “dopo”, che la missione non era finita in Tanzania.

“Cosa funziona di più secondo te per far avvicinare la gente ad una tematica che fotografi? Un articolo su una rivista, una foto su un quotidiano, le immagini sul web o social, una mostra, un evento, un libro? qual è la cosa che tu vedi che alla fine colpisce di più?“
Non è una domanda semplice da per rispondere perché forse dipende dal tema che si tratta certamente l’impatto social è come dicevamo il più il più immediato e quindi funziona sicuramente. Però credimi anche le altre modalità arrivano, dipende dal target e dalla tematica, e forse è proprio l’insieme delle tante attività che raggiunge più persone.
“L’ultima domanda per te, questo lo chiediamo a tutte le persone che intervistiamo come Frame for Life, perché vogliamo dare stimoli ai giovani che vogliono crescere in quest’ambito: cosa diresti a un giovane fotografo che voglia impegnarsi nel sociale o nel mondo? Per esempio, quali errori evitare, che magari tu hai fatto o quale consiglio ti sentiresti di dare?”
Nella massima serenità, intanto, di farla questa esperienza!
Nel lavorare con la fotografia per il sociale la cosa più bella che si può fare e beh ascoltare le persone, mescolarsi tra la gente del posto e scattare delle fotografie entrando nella scena da vicino. Ma con rispetto, senza invadere la loro vita, la loro casa, la loro terra.
Pensando all’inquadratura, invece, una mia vecchia insegnante di fotografia mi diceva “tu hai messo troppa roba qua, c’è troppa roba qui, leva, leva” e quindi comporre andando dritti al punto. E poi, non credere di aver capito tutto subito perché quello può essere un errore che tu arrivi dici vabbè qui faccio così io già so tutto e quello che devo fare invece no: prendersi tempo, aspettare e poi aspettare la luce giusta, e fare clic -come diceva il più grande- con la testa, l’occhio e il cuore.
E a quel punto hai lo scatto vero, quello che racconta, quello che emoziona, quello che arriva. Ecco, allora il consiglio più importante, non permettere mai a nessuno di limitare il tuo messaggio, di mettere dei filtri, di censurare. Tu sei un testimone, nessuno ti deve togliere questa opportunità di mostrare al mondo cosa hai visto.

Intervista a cura di Silvia Superbi, presidente di Frame for life.
Riprese video di Giorgio Pincitore.